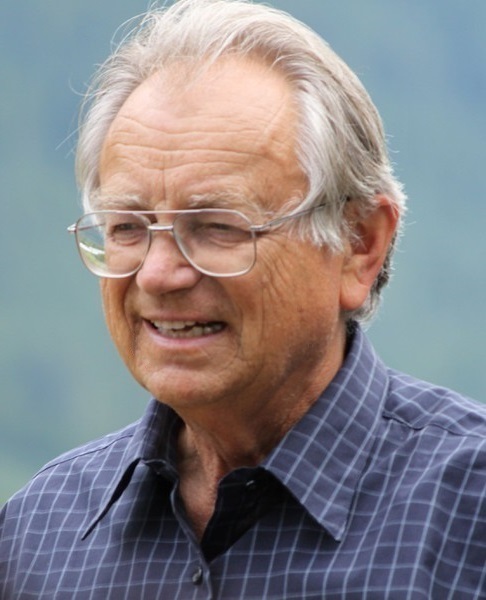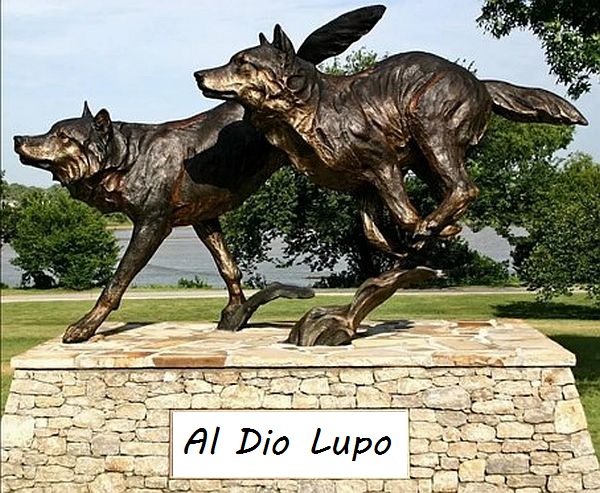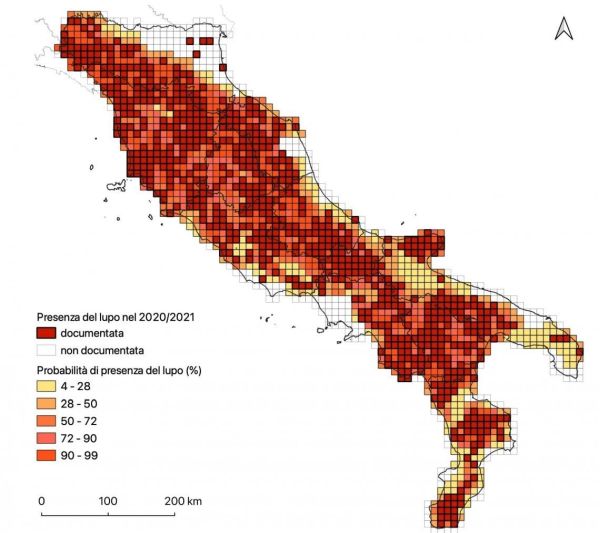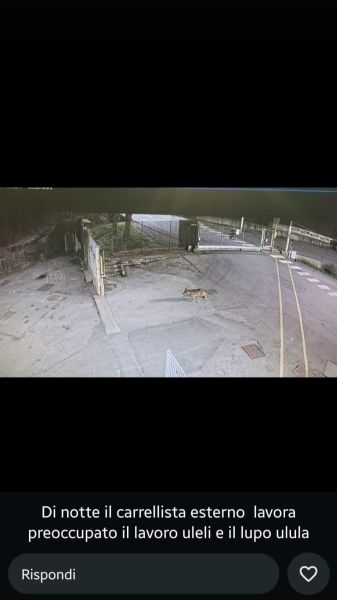Il
7 marzo la Commissione europea, preso atto che non si sono registrate
opposizioni alla decisione della Commissione permanente della
Convenzione di Berna tenutasi agli inizi di dicembre 2024, che,
quindi, in sede di Convenzione e di Consiglio d'Europa (che
comprende diversi altri stati oltre i 27 della Ue), l'iter di
declassamento si è concluso, ha approvato una proposta di modifica
mirata degli allegati IV e V della direttiva Habitat (che recepisce la
Convenzione di Berna) per quanto riguarda lo status di protezione del
lupo. La proposta dovrà ora essere adottata dal Parlamento europeo e
dal Consiglio dei ministri.
La Commissione propone una modifica mirata
agli allegati della direttiva Habitat attraverso un emendamento
piuttosto semplice, così come delineato nell’articolo 1 della proposta:
cancellazione
della specie Canis lupus dall’allegato IV (protezione rigorosa) e
aggiunta di Canis lupus all’allegato V (protetto ma con flessibilità
gestionale).
e nell' l’articolo 2
gli Stati
membri avranno 18 mesi di tempo dalla data di entrata in vigore della
presente direttiva modificata per attuare la decisione.
La tempistica per l’adozione da parte del Parlamento europeo e del
Consiglio non è ancora stata fissata, ma la Commissione si aspetta una
rapida approvazione dell’emendamento e l'on. Fiocchi ritiene che la
modifica possa essere approvata entro l'estate. Spesso il decreto legislativo di adeguamento viene emanato
dal governo (previo parere delle camere) anche prima di 18 mesi.
Ragionevolmente, possiamo quindi prevedere l'approvazione nell'autunno 2026.

Il procedimento di declassamento è stato
deciso sulla base delle discussioni e delle risoluzioni del Parlamento
europeo (peraltro mai molto risolutive ed esenti da ambiguità). E'
stata la Commissione che, sulla base dei rapporti scientifici compilati
dagli esperti e sulla considerazione dello stato
di conservazione nei diversi paesi e a livello contintale, ha impresso
una svolta.
Il primo dei
rapporti in questione è quello prodotto dai soliti lupologi della LCIE
(presidente
il "signore dei lupi", Boitani) nel 2022. In quella occasione i paesi
della UE votarono, ancora una volta (era la Svizzera che, per la terza
volta lo proponeva) contro il
declassamento nonostante le evidenze scientifiche a favore del
provvedimento contenute nel rapporto redatto ad hoc.
I lupologi, nonostante la loro lupofilia, erano
stati a malincuore costretti ad ammettere che la crescita del lupo rappresenta un fenomeno
generale in Europa, che solo in qualche paese balcanico, dove sono
comunque molto numerosi, è in diminuzione. Dovevano anche ammettere che, nella maggior parte dei
paesi è in atto una forte crescita, che non accenna a diminuire (vai al documento).
La proposta della Commissione europea del dicembre 2023 di
declassamento del lupo è arrivata dopo l'esame di un'altro
rapporto degli esperti European Commission: Directorate-General for Environment, Blanco, J. and Sundseth, K., The situation of the wolf (canis lupus) in the European union – An in-depth analysis, Publications Office of the European Union, 2023, https://data.europa.eu/doi/10.2779/187513
. Basti dire che, nei 24 paesi continentali della Ue, ovvero eccettuate
le isole-stato senza lupi : Irlanda, Malta - paesi che, elegantemente,
si sono opposti al declassamento anche in sede di Consigli dei ministri
Ue - e Cipro, si stimavano, nel
2023, 20.300 lupi. Un dato da confrontare con quello del 2012
(11.193 lupi).

Che il WWF, la Lav, l'Enpa abbiano lanciato
campagne isteriche contro il declassamento, che gli
animal-ambientalisti abbiano utilizzato tutta la loro capacità di
presenza sui media main stream, che abbiano lanciato petizioni e
costruito sondaggi farlocchi (da loro sponsorizzati) nei quali
risultava che i pastori, a larga maggioranza, sono contrari al
declassamento, che abbiano presentato ricorsi alla Corte europea di
Giustizia, ci sta. Temono di perdere la gallina dalle uova d'oro, la
loro bandiera, il loro bancomat. Non ci sta che Boitani, che ha firmato
i rapporti scientifici che attestano che lo status di conservazione del
lupo non è più tale da corrispondere alle motivazioni che avevano
giustificato il regime di protezione rigorosa ai sensi della
Convenzione di Berna e della Direttiva Habitat, affermi che il
declassamento non ha basi scientifiche. E' solo l'ennesima
manifestazione della disonestà intellettuale del personaggio. Un
personaggio che, mentre da studioso firma rapporti nei quali si
elencano le vittime delle aggressioni da lupo in Europa (fonte),
da imprenditore politico-economico del lupo (capace di portare a casa a
ripetizione progetti Life milionari sul lupo, a vantaggio
dell'associazione IEA costituita da lui stesso e da pochi collaboratori
) in occasione della Giornata mondiale della fauna selvatica,
nell'articolo “Convivere con orsi e lupi si può”, pubblicato su La
Repubblica del 3 marzo 2025, continua a sostenere che non ci sono
documentazioni di attacchi del lupo all'uomo.

Quale strategia la lobby può mettere in campo per bloccare l'attuazione in Italia del declassamento?
L'Italia è stato uno dei paesi a votare a
favore del declassamento; è anche quello che ha più lupi in tutta
l'Unione Europea e, per di più, con una popolazione in costante
crescita che sta colonizzando aree di pianura ad agricoltura intensiva,
coste, aree urbane, segno di una saturazione delle aree montane e di
collina interna che spinge il surplus demografico a cercare nuovi spazi
anche in zone con assenza o scarsità delle prede "convenzionali" della
specie. Come ammettono anche i rapporti sopra citati, la colonizzazione
di ambienti fortemente antropizzati determina l'insorgere del fenomeno
dei bold wolves (lupi spavaldi che hanno perso ogni timore nei
confronti dell'uomo, che siano stati abituati da offerte alimentari e
socializzati o meno). La presenza dei lupi nelle città, l'intrusione
nei giardini, nei cortili, negli annessi alle abitazioni è diventata
ormai frequente. I lupi sono avvistati ogni giorno in aree abitate
anche in pieno giorno. In queste condizioni diventa improponibile non
recepire il declassamento nella normativa nazionale (dpr 357 del 1997
di recepimento della direttiva Habitat e legge 157 del 1992). Si deve
cercare di operare d'astuzia, sfruttando i punti deboli della politica.

Il precedente delle deroghe
Negli anni scorsi ne abbiamo sentite di tutti
i colori in tema di deroghe. Assessori regionali, consiglieri,
onorevoli e senatori si erano fatti convincere dalla burocrazia
(regionale o ministeriale) che "le deroghe non si possono applicare".
Continuavano a ripeterlo, per giustificare davanti agli allevatori e ai
cittadini che "le regioni hanno le mani legate" anche in barba al fatto
che, senza dare pubblicità alla cosa, le regioni (e in qualche caso
anche i parchi nazionali) le deroghe le stavano utilizzando. Sono state
utilizzate in Puglia, Abruzzo, Lazio, Marche, Veneto, Piemonte (che noi
si sappia). Di solito per catturare lupi che avevano aggredito delle
persone, a volte solo perché si erano dimostrati "confidenti". Tutto
era tenuto sotto traccia. Per giustificare il mancato ricorso alle
deroghe, veniva anche detto che: "Non è possibile se non viene
approvato il Piano lupo". Era una balla colossale perché, come già
detto, più o meno di nascosto, le regioni le deroghe le hanno
applicate. In realtà, in una delle diverse versioni delle "Linee guide
per l'applicazione delle deroghe" emanate dalla Commissione europea,
era scritto che: "l'applicazione delle deroghe può essere avegolata
dalla redazione di piani di azione nazionali". Veniva comunque
precisato che, comunque, le deroghe potevano essere applicate in ogni
caso, precisazione doverosa perché uno strumento interpretativo non può
porre condizioni limitative di applicabilità di una norma. Era solo una
raccomandazione (in quanto la Commissione avrebbe potuto valutare più
facilmente le relazioni nazionali, che vengono redatte ogni due anni, a
posteriori, dagli stati membri, alla luce di criteri nazionali
espliciti). Tanto bastò che in ambito politico si spargesse la fake
della condizionalità delle deroghe al piano lupo. Più grossolanamente,
alcune regioni giustificavano la loro inerzia raccontando che: "In
Italia le deroghe sono attuate dal Ministero". Una fake che presuppone
la non conoscenza del titolo V della Costituzione e del dpr 357/97 di
recepimento della direttiva Habitat. In Italia le deroghe le chiedono
le regioni e i parchi nazionali (che sono riusciti a infiltrarsi nella
norma) e sono autorizzate dal Ministero dell'ambiente sentito il parere
dell'Ispra. L'ultima fake riguarda la necessità di adottare le misure
di difesa passiva. La Regione Veneto ha approvato un progetto da 400
mila euro (beneficiarie le Università di Padova e di Sassari) con la
motivazione che, non potendo essere applicata la deroga dove non ci
sono cani, reti, pastori

Il 4 dicembre 2024, in un incontro pubblico
sul lupo a Erbezzo (Verona), il sen Paolo Tosato, che pure dichiarava,
sinceramente, di comprendere i problemi degli allevatori, ripeteva la
fake: "In Italia le deroghe non possono essere applicate". Di fronte
alle proteste di chi scrive, ribadiva che "me lo hanno detto al
Ministero dlel'ambiente". A settembre, un mese e mezzo prima, la
Regione Veneto (o meglio, la squadra catture dell'Università di
Sassari, in una regione notoriamente piena di lupi) aveva catturato la
"lupa del Pieve" e l'aveva segretamente trasferita all'Università di
Udine. Il Ministero aveva autorizzato anche l0'abbattimento, ma
la Regione, per viltà, ha, come in altri casi, optato per la soluzione
politicamente meno problematica. Un politico non avrebbe il dovere di
informarsi, di leggere le norme, di documentarsi? Cosa li paghiamo
(meglio che negli altri paesi europei) per fare? Perché bevono le
menzogne che gli propina la burocrazia contigua alle lobby
animal-ambientaliste?

Dribblare il declassamento
Con questi vergognosi precedenti, possiamo pensare che la politica ignava, che sente più il fiato sul collo delle
potenti lobby animal-ambientaliste (le organizzazioni professionali
agricole è come se non esistessero quando si tratta di fare una
battaglia di questo tipo), rinunci a continuare a prendere in giro gli
allevatori italiani e le popolazioni rurali, esasperate per la
crescente invadenza e spavalderia dei lupi?Nel mentre stanno tenendo buoni i soggetti rurali con il declassamento, stanno pensando a come renderlo inoperativo.
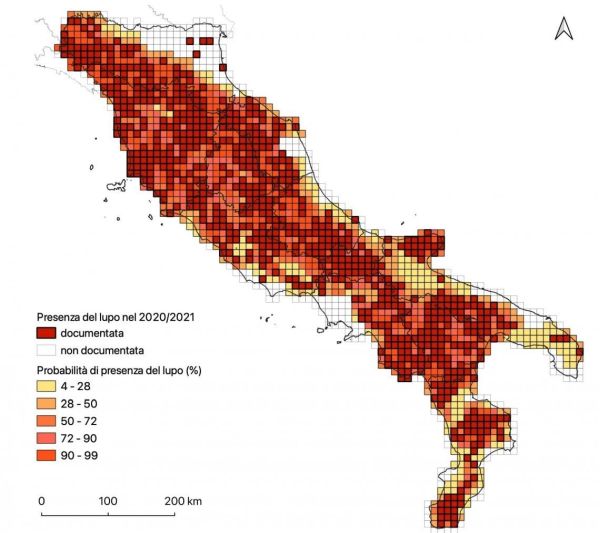
Sopra: la mappa della presenza. Non vengono
però dichiarati i dati numerici per regione (eppure il monitoraggio
costò 1,5 milioni di euro)
L'Ispra, rispondendo a una
sollecitazione del ministro Picchetto Frattin, ha pubblicizzato delle
"quote" di possibili abbattimenti per regione. Sul significato di
questa mossa torniamo dopo. Ci sono dei numeri per il Piemonte,
il Trentino, il Veneto, la Toscana, l'Emilia Romagna. In
Piemonte si potranno abbattere - al massimo-, bontà dell'Ispra, da 10 a
17 lupi. Ovviamente, dal momento che siamo sempre in regime di deroghe,
solo se ne combireranno di cotte e di crude. Qualcuno ha parlato di
"piani di abbattimento" (era carnevale). In Piemonte dal 1° gennaio al
6 marzo sono stati stirati stecchiti sulle strade 25 lupi. Gli scorsi
anni sono stati 75 all'anno. Dal momento che gli studi dei lupologi ci
dicono che la mortalità stradale rappresenta circa la metà di quella
totale, in Piemonte sarebbero morti negli ultimi anni sui 150 lupi
all'anno. Servono dei salti mortali tripli carpiati per conciliare
questa mortalità con la ridicola stima di 330 lupi presenti in Piemonte
nel 2020/21 (e non ancora aggiornata per il 2023/24 per l'inammissible
ritardo di Life Wolf Alps). Su questa ridicola stima si calcola,
intanto, il "prelievo" del 3-5%.Più ritardano le nuove stime e più bassa è la quota.
Per capire come la "concessione" dell'Ispra
sia una solenne presa in giro, basti ricordare che il Piano lupo del
ministro Galeltti del 2017 prevedeva una quota massima del 5%. Quindi
l'Ispra, con il dilagare dei lupi tra il 2017 e oggi, cosa fa? Tira
ancora il freno. Se, in Piemonte, queste "quote" che non compromettono
il buono stato di conservazione della specie", sono ridicole e
offensive per chi subisce i danni da parte dei lupi (in gran parte non
denunciati per sfiducia nelle istituzioni ritenute - giustamente - pro
lupo). Ci si chiede poi cosa ne sarà delle regioni dove l'Ispra non ha
prodotto una stima? Chi si ricorda il monitoraggio del 2020-21 sa che,
per tutte le regioni appenniniche in blocco si calcolavano 2400 lupi.
Come è possibile allora stabilire quote per la Toscana e
l'Emilia-Romagna? Perché, ci sono monitoraggi regionali. E dove non ci
sono? Nella Regione Abruzzo, grazie all'insistenza di Dino Rossi
(presidente del Cospa Abruzzo e vice-presidente dell'Associazione
nazionale per la tutela dell'ambiente e della vita rurali) lo
zooprofilattico ha finalmente fornito i dati dei lupi vittime degli
incidenti stradali: sono 100 all'anno, più che in Piemonte. Logico che
in Abruzzo ci siano 1000 lupi . La Toscana dichiara 500-800 lupi. In
Emilia Romagna sono poco meno che in Toscana. Siamo, prudenzialmente, a
200o lupi. Chi crede che nelle Marche, Umbria, Lazio, Puglia, Calabria,
Basilicata ce ne siano solo 400. I numeri non tornano.

A cosa serve la mossa dell'Ispra?
Chi segue da tempo la politica del lupo in
Italia non ha potuto fare a meno di chidersi il significato della mossa
dell'Ispra. Esso va letto alla luce del declassamento che, come detto
all'inizio, non potrà non essere messo in attoentro il 2026. Nonostante le tappe del declassamento procedano regolarmente e
non possano esserci più ostacoli (il ricorso della lobby alla Corte
europea di giustizia è una mossa ad uso degli sprovveduti che
effettuano donazioni per "salvare il povero lupo"), c'è, tra i
politici, in particolare tra i sottosegretari all'agricoltura, qualcuno
che cerca ancora di convincere i politici regionali ad approvare il
Piano lupo. "Ci vorranno anni per il declassamento". Una fake. L'Europa
deve solo approvare quei due articoletti citati all'inizio: il lupo
passa dall'allegato IV all'allegato V della direttiva; la modifica deve
essere recepita entri 18 mesi. Come si fa a sostenere che ci vogliono
gli anni? Il motivo, invece, è chiaro: accettare un Piano lupo nel
2025, con tutti i vincoli del regime ante declassamento, con la
necessità di sottostare all'autorizzazione ministeriale e, soprattutto
con la necessità di dover dimostrare caso per caso che sussistono: la
gravità e la reiterazione dei danni, l'uso di cani e altri presidi. Il
tutto con il miraggio, ovvero con la cigliegina di quel 3-5% di
abbattimenti massimi (ecco la funzione di esca dell'uscita estemporanea
dell'Ispra) che si incaricheranno i tanti paletti che saranno messi di
mezzo a vanificare del tutto. Non è la scelta tra un uovo oggi e la
gallina domani, è la presa per i fondelli pura e semplice.
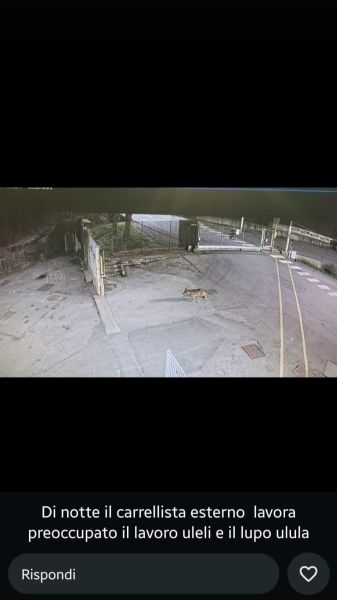
Con il declassamento, invece, le regioni potranno tranquillamente gestire
il lupo, prescindendo da singoli casi, ovvero gestendo la specie sulla
base della sua abbondanza, delle dinamiche di popolazione, dell'entità
dei danni provocati: ci sono tot lupi? Bon, per ripristinare un
equilibrio serve toglierne il tot %. Fine della mistica del lupo, fine
della pacchia per il sottobosco che specula sul lupo. Ovviamente, chi
ci ha marciato per anni, tenterà il tutto per tutto per non arrivare a
questo. Fortunatamente, le regioni stanno subendo sempre di più le
sollecitazioni dalle categorie e dalle comunità locali, esasperate
dalla presenza incombente dei lupi e dai danni da essi provocati. Se,
sino a qualche anno fa, l'effetto del ricatto animalista poteva pesare
in modo determinante sul comportamento delle regioni, oggi vi sono
spinte che lo controbilanciano e che diventeranno sempre più forti. In
un contesto di discredito del Green deal e di tutte le politiche
pseudoambientaloiste. Chiamiamolo effetto Trump.
In conclusione: usando il mitico
declassamento, inseguito da anni, per dimostrare che la politica non ha
lasciati soli gli allevatori e qualcosa si è ottenuto, si cerca di
tenerli buoni e, così ammansiti, di rimandare il più in là possibile
l'effettiva messa in opera del declassamento stesso. Abbiamo visto che
è da 10 anni che si discute inutilmente di Piano lupo. Ogni volta che
si è arrivati a una conclusione, una o più regioni si sono sfilate (di
solito per tutelare a oltranza il lupo). Ultimamente si è sfilata,
sostenendo che il Piano non garantiva gli allevatori, non risolveva il
problema degli ibridi ecc., la Regione Piemonte (ma era la giunta
precedente che, dopo anni, aveva iniziato a capire il problema e a non
ascoltare solo i funzionari faziosi, con i nuovi amministratori c'è da
lavorare).
Qualche segnale positivo è però arrivato, negli ultimi mesi, dalla Toscana e dalla Lombardia, con delle mozioni dei consigli che
chiedono effettettivi monitoraggi utili alla gestione, con dati
numerici aggiornati e per aree omogenee e l'attribuzione certadelle predazioni a ogni tipo di animale (ma anche delle aggressioni alle persone), al lupo piuttosto che a ibridi o cani
. Confidiamo che, almeno queste regioni, si rifiutino di cadere in una
trappola che condannerebbe a morte gli allevamenti estensivi
sopravissuti e comprometterebbe la permanenza delle comunità rurali
nelle loro sedi.